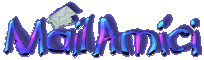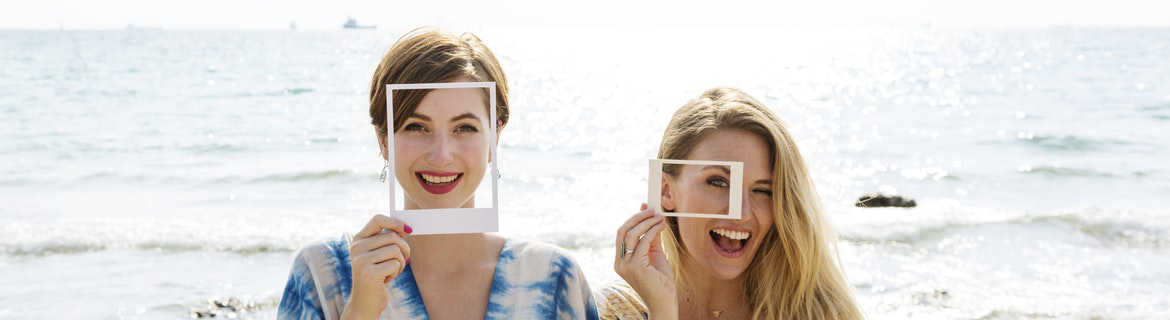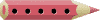amary ha scritto:Vi chiedo di scrivere qui uno stralcio che vi ha particolarmente colpito di un libro che avete letto.
"Nella perfezione in cui già ci si presentano in Omero, gli Dèi greci non possono certo intendersi come prodotti della necessità e del bisogno: tali esseri sicuramente non sono stati inventati da un animo scosso dall'angoscia. Non è per ritrarsi dalla vita, che una geniale fantasia ha proiettato nel vuoto le loro immagini. Attraverso queste parla una religione della vita, non già una religione del dovere o dell'ascetismo o della spiritualità. Tutte queste figure esprimono il trionfo dell'esistenza, un rigoglioso sentimento di vita accompagna il loro culto. Esse non pretendono: in loro è divinizzare ciò che sussiste, sia esso buono o cattivo.
(...) Perciò una teodicea non fu mai un problema ellenico: ci si guardò
dall'addossare agli dèi l'esistenza del mondo, e quindi la responsabilità per la sua configurazione. Anche gli dèi sono sottomessi all'anánke":questo è un riconoscimento della più rara sapienza.
Vedere la propria esistenza - quale si
presenta - in uno specchio trasfigurante, e difendersi con questo specchio dalla Medusa, ecco la strategia geniale della «volontà» ellenica, in generale per poter vivere. Come avrebbe infatti potuto sopportare altrimenti l'esistenza quel popolo infinitamente sensibile, così splendidamente recettivo al dolore, se tale esistenza non gli si fosse rivelata, avvolta da una gloria superiore, nei suoi dèi? Lo stesso impulso che trae alla vita l'arte, in quanto integrazione e compimento che inducono a continuare la vita, fece sorgere altresì il mondo olimpico, un mondo della bellezza,della quiete, del godimento. Sotto l'influsso di una tale religione, la vita viene intesa nel mondo omerico come qualcosa in sé desiderabile: la vita cioè nel chiaro splendore solare di tali Dèi.
Si tratta del mondo trasfigurato dell'occhio, che crea artisticamente nel sogno, con le palpebre abbassate. La contemplazione, la bellezza e l'illusione circoscrivono la sfera dell'arte apollinea.Anche la poesia epica vuol condurci a questo stato di sogno: non dobbiamo veder nulla con gli occhi aperti e dobbiamo pascerci delle immagini interiori, alla cui produzione cerca di stimolarci il rapsodo con i suoi concetti.(…) La misura, sotto il cui giogo si moveva il nuovo mondo di dèi olimpii (di fronte al mondo abbattuto dei Titani), era quella della bellezza: il limite che il Greco doveva mantenere era quello della bella illusione. Il fine più intimo di una cultura rivolta all'illusione e alla misura può certo essere soltanto quello di velare la verità. L'instancabile indagatore al servizio della verità così come il tracotante Titano, viene richiamato con l'ammonizione del medén ágan.Con Prometeo viene mostrato alla grecità un esempio di come un eccessivo avanzamento della conoscenza umana agisca in modo ugualmente rovinoso per chi promuove tale avanzamento e per chi ne usufruisce.In un mondo così costruito e artificiosamente difeso penetrò allora il suono estatico della festa di Dioniso, dove tutto l'eccesso della natura in gioia, dolore e conoscenza si manifestò in uno stesso tempo. Tutto quello che sino allora valeva come limite e come determinazione di misura si dimostrò a quel punto una artificiosa illusione: l' «eccesso» si svelò come verità.(...) E la cosa più misteriosa si realizzò: venne allora al mondo l'armonia, che nel suo movimento fa immediatamente comprendere la volontà della natura. In compagnia di Dioniso si fecero ormai udire cose che nel mondo apollineo stavano artificiosamente nascoste: tutto il fulgore degli dèi olimpici impallidì dinnanzi alla sapienza di Sileno. Un'arte che nella sua ebbrezza estatica diceva la verità, scacciò le Muse delle arti dell'illusione; nell'oblio di sé degli stati dionisiaci perì l'individuo con i suoi limiti e le sue misure: eminente un crepuscolo degli Dèi (del” politeismo perfetto”).
F. Nietzsche "La visione dionisiaca del mondo"